
Autore: Angelo Cafà
•
30 gennaio 2026
Il dibattito parlamentare sulle maggiori tutele legali per le forze dell'ordine, impropriamente definito "scudo penale", merita un'analisi approfondita che vada oltre le semplificazioni mediatiche per cogliere le reali implicazioni giuridiche di una riforma che, pur animata da intenti comprensibili, presenta profili di criticità che potrebbero rivelarsi controproducenti per gli stessi soggetti che si intende proteggere. La proposta normativa in discussione, come chiarito dalle fonti governative e dai rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine, non configura alcuna forma di impunità ma mira a introdurre un meccanismo che eviti l'iscrizione automatica nel registro degli indagati quando sia evidente che l'appartenente alle forze dell'ordine ha utilizzato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale approccio si fonda sulla constatazione che l'attuale sistema, disciplinato dall'articolo 335 del Codice di procedura penale, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente nel registro ogni notizia di reato, senza alcuna discrezionalità valutativa. Tuttavia, questa impostazione rivela una comprensione parziale della natura e della funzione dell'iscrizione nel registro degli indagati. Contrariamente a quanto suggerito dal dibattito politico, l'iscrizione non costituisce un "marchio d'infamia" o una forma di condanna anticipata, ma rappresenta una garanzia fondamentale per la persona sottoposta alle indagini. Questa considerazione assume particolare rilevanza quando si consideri che l'articolo 360 del Codice di procedura penale disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, stabilendo che il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini della facoltà di nominare consulenti tecnici e di assistere agli accertamenti. Il meccanismo proposto rischia di creare una situazione paradossale: l'agente di polizia che non risulti iscritto nel registro degli indagati non potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili che potrebbero riguardare la sua condotta. Qualora da tali accertamenti emergessero profili di responsabilità penale, l'interessato si troverebbe a partecipare al processo senza aver potuto assistere a fasi investigative cruciali, con evidente pregiudizio per i suoi diritti di difesa. Questa criticità assume particolare rilievo nei casi di uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, dove gli accertamenti balistici, le ricostruzioni della dinamica dei fatti e le analisi delle tracce ematiche costituiscono spesso elementi probatori decisivi. Ben diversa è la valutazione della previsione di sostegno economico per le spese legali. L'articolo 98 del Codice di procedura penale già prevede che l'imputato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. Tuttavia, una specifica previsione per gli appartenenti alle forze dell'ordine indagati per fatti inerenti al servizio rappresenterebbe un intervento equilibrato e costituzionalmente compatibile. La tutela legale rappresenta, a mio avviso, l'unico aspetto della proposta che merita di essere rafforzato, poiché risponde a un'esigenza concreta senza alterare l'equilibrio processuale. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, spesso chiamati a operare in situazioni di particolare complessità e pericolosità, devono poter contare su un adeguato supporto legale quando la loro condotta professionale diventi oggetto di indagini. Il vero problema non risiede nell'iscrizione nel registro degli indagati in sé, ma nella gestione mediatica e nell'uso improprio che talvolta viene fatto delle informazioni di garanzia. La soluzione dovrebbe essere ricercata in una maggiore tutela della riservatezza delle indagini e in una più rigorosa applicazione delle norme sul segreto investigativo, piuttosto che nella modifica di meccanismi processuali che garantiscono i diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini. La proposta di evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, pur animata da intenti comprensibili, rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. L'iscrizione nel registro non è una sanzione, ma uno strumento di garanzia che consente all'interessato di esercitare pienamente i propri diritti di difesa fin dalle prime fasi delle indagini. Un agente di polizia che non possa partecipare agli accertamenti irripetibili relativi alla propria condotta si troverebbe in una posizione di svantaggio processuale che nessuna norma di favore potrebbe successivamente compensare. L'equilibrio tra esigenze di tutela degli operatori delle forze dell'ordine e garanzie processuali può essere raggiunto attraverso strumenti che non compromettano i diritti di difesa. Il sostegno economico per le spese legali rappresenta la strada maestra, mentre ogni intervento sui meccanismi di iscrizione nel registro degli indagati rischia di creare pericolosi precedenti che potrebbero estendersi ad altre categorie professionali, minando i principi fondamentali del processo penale. La tutela delle forze dell'ordine passa attraverso la valorizzazione del loro ruolo istituzionale e il riconoscimento delle difficoltà operative che quotidianamente affrontano, non attraverso modifiche procedurali che potrebbero rivelarsi controproducenti. La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio che tuteli concretamente gli operatori delle forze dell'ordine senza compromettere quei principi di garanzia che costituiscono il fondamento dello Stato di diritto.

Autore: Angelo Cafà
•
30 gennaio 2026
La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici nelle indagini per spaccio di sostanze stupefacenti delinea un quadro interpretativo di particolare complessità, caratterizzato dalla necessità di bilanciare le legittime esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta alle indagini. La questione assume rilievo centrale nell'odierna prassi giudiziaria, considerata l'ubiquità dei dispositivi elettronici nella vita quotidiana e la loro capacità di contenere una massa eterogenea di dati personali che trascende spesso i confini dell'indagine in corso. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di legittimità di tali provvedimenti, elaborando principi che si pongono come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Il principio cardine che emerge dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte attiene all'obbligo di motivazione rafforzata del decreto di sequestro probatorio quando questo abbia ad oggetto dispositivi informatici. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37217 del 14 novembre 2025, il decreto del pubblico ministero deve illustrare "le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse". Tale orientamento trova fondamento nell'applicazione analogica dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'articolo 275 del Codice di procedura penale alle misure cautelari reali. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5526 del 11 febbraio 2025 ha precisato che tali principi "devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica". La specificità dei dispositivi informatici richiede particolare attenzione nella valutazione della proporzionalità della misura. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38792 del 1 dicembre 2025, "il sequestro di dispositivi informatici costituisce misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto fornisce un quadro completo di aspetti significativi della vita passata e attuale degli interessati". Un aspetto di particolare rilevanza concerne i limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di sequestro individuando autonomamente le finalità probatorie. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1648 del 15 gennaio 2026 ha stabilito che "il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del provvedimento di convalida individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari". Questo principio trova conferma nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9347 del 5 marzo 2024, che ha annullato un sequestro probatorio ritenendo "illegittima l'opera di integrazione compiuta dal Tribunale" che aveva autonomamente collegato i telefoni cellulari sequestrati alla necessità di verificare i contatti con i clienti, in assenza di specifiche indicazioni del pubblico ministero. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti sussiste una presunzione di pertinenzialità dei dispositivi di comunicazione rispetto alle finalità investigative. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18139 del 14 maggio 2025 ha precisato che "nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'esigenza di procedere al sequestro degli apparecchi di comunicazione detenuti dall'indagato è giustificata dalla necessità di verificare i contatti avuti sia con i possibili fornitori della sostanza sia con i potenziali acquirenti della medesima". Tale orientamento trova ulteriore conferma nella Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36363 del 7 novembre 2025, secondo cui "il contenuto dei telefoni cellulari costituisce la fonte informativa primaria per l'accertamento della rete illegale di fornitori e clienti in cui uno spacciatore necessariamente agisce". Un profilo di particolare interesse attiene alla modulazione dell'onere motivazionale in relazione alle diverse fasi processuali e alla natura del reato. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15201 del 17 aprile 2025 ha chiarito che "l'onere motivazionale deve essere modulato in relazione al caso concreto, tenendo conto della natura del reato ipotizzato, del tipo di bene sequestrato e della relazione che le cose presentano con l'illecito". Un aspetto critico emerge dalla necessità di evitare che il sequestro assuma carattere meramente esplorativo. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4169 del 7 febbraio 2022 ha stabilito che "è vietata l'acquisizione indiscriminata di dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari o personal computer, contenenti masse indistinte di dati informatici, in difetto di specifiche ragioni che ne giustifichino la pertinenza rispetto al fatto di reato contestato". La questione della reiterazione del sequestro dopo annullamento per vizi formali ha trovato chiarimento nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6587 del 18 febbraio 2025, che ha precisato come "l'annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non determina alcuna preclusione processuale alla reiterazione della misura" quando l'annullamento sia intervenuto per profili formali senza valutazione dei presupposti sostanziali. La giurisprudenza ha inoltre affrontato la delicata questione dei criteri di selezione dei dati. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22595 del 5 giugno 2024 ha chiarito che "il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto". L'evoluzione giurisprudenziale delineata evidenzia come la Suprema Corte stia progressivamente affinando i criteri di legittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici, bilanciando le esigenze investigative con la tutela dei diritti fondamentali. La tendenza emergente privilegia un approccio garantista che richiede motivazioni specifiche e circostanziate, criteri di selezione chiari e tempi definiti per l'analisi dei dati, ponendosi come argine contro derive investigative di carattere meramente esplorativo. Tale orientamento si inserisce nel più ampio contesto dell'evoluzione del diritto processuale penale verso forme di tutela sempre più raffinate dei diritti della persona, anche nelle fasi preliminari del procedimento, confermando come il principio di proporzionalità costituisca ormai un parametro irrinunciabile nella valutazione della legittimità delle misure cautelari reali, particolarmente quando queste incidano su beni di natura informatica caratterizzati da elevata invasività nella sfera personale dell'indagato.

Autore: Angelo Cafà
•
27 gennaio 2026
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dei minori nell'ambiente scolastico ha delineato principi fondamentali che ridefiniscono i limiti del potere educativo, escludendo definitivamente ogni forma di violenza dal perimetro delle condotte lecite. Una recente pronuncia della Cassazione ha offerto spunti di riflessione sulla delicata distinzione tra correzione educativa e maltrattamento, con particolare attenzione alla tutela del minore "testimone" di violenza. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi. Questo principio trova fondamento nell'evoluzione culturale e normativa che ha investito la concezione dei diritti del minore, non più considerato mero oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti fondamentali. L'articolo 571 del codice penale presuppone infatti l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. La Cassazione ha precisato che il criterio distintivo fra la fattispecie ex art. 571 c.p. e i delitti contro la persona deve individuarsi nell'astratta liceità del mezzo educativo-correttivo utilizzato. Quando le condotte educative si caratterizzano per l'uso sistematico della violenza, si configura necessariamente il più grave reato di maltrattamenti in famiglia. Un aspetto particolarmente significativo della giurisprudenza consolidata riguarda l'impossibilità di invocare concezioni socio-culturali diverse per giustificare l'uso della violenza educativa. La Cassazione ha chiarito che non può essere adottato un diverso criterio interpretativo in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore il soggetto agente, posto che vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento consacrati negli articoli 2, 3, 30 e 32 della Costituzione. Questi principi fanno parte del consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui essa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe soggettive né possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel territorio nazionale. Tale orientamento riflette una concezione personalistica che pone al centro la dignità del minore e il suo diritto al pieno sviluppo della personalità, indipendentemente dalle tradizioni culturali di provenienza dell'educatore. Una delle innovazioni più significative degli ultimi anni riguarda la tutela del minore che assiste ai maltrattamenti. L'articolo 572, comma 4, del codice penale stabilisce espressamente che "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato". Questa disposizione ha operato una vera e propria rivoluzione concettuale, riconoscendo il danno psicologico derivante dalla mera assistenza a episodi di violenza. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcun distinguo giuridicamente rilevante tra vittima di maltrattamenti diretti e vittima di maltrattamenti assistiti, essendo entrambe le figure riconducibili alla nozione di persona offesa dal reato. Questo principio ha trovato applicazione anche nell'ambito scolastico, dove la presenza di altri minori durante episodi di violenza configura automaticamente la loro qualità di persone offese. Un ulteriore sviluppo giurisprudenziale di particolare rilievo riguarda la parificazione, dal punto di vista del diritto al risarcimento del danno, tra i fatti commessi "in presenza" e quelli commessi "in danno" del minore. La Cassazione ha precisato che per la configurabilità dell'aggravante della presenza del minore non è necessario che questi assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo sufficiente che percepisca anche un solo episodio di condotta maltrattante. Questa evoluzione risponde al principio secondo cui la finalità principale è quella di salvaguardare l'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità. La violenza assistita punisce la sofferenza del minore sotto due profili: direttamente, per il solo fatto di essere presente, e indirettamente, per la percepita afflizione cui è soggetto il genitore vittima. La condizione della "presenza" non va interpretata in senso formalistico, non essendo richiesta la mera presenza materiale nel luogo in cui si verificano gli episodi di maltrattamento. Ciò che rileva è che la presenza sia "partecipe", il che si verifica quando il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche anche soltanto per via uditiva. La disposizione mira a tutelare il corretto sviluppo psicofisico del minore da ogni forma di coinvolgimento nell'evento lesivo, coinvolgendo tutte le componenti sensoriali mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni. Quando le condotte maltrattanti si reiterino per un periodo prolungato, è logico ritenere che alla loro realizzazione assistano minorenni conviventi, i quali condividono inevitabilmente gli spazi vitali, soprattutto se ancora in tenera età. Questi orientamenti giurisprudenziali hanno profonde implicazioni per tutti coloro che operano nell'ambito educativo. Gli insegnanti, gli educatori e il personale scolastico devono essere consapevoli che qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, esula completamente dal perimetro delle condotte lecite, indipendentemente dalle intenzioni educative che possano animarla. La responsabilità educativa richiede l'adozione di metodologie pedagogiche rispettose della dignità del minore, fondate sul dialogo, sulla comprensione e sull'utilizzo di strumenti correttivi proporzionati e non lesivi dell'integrità psicofisica. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di altri minori durante eventuali interventi correttivi, poiché anche la mera assistenza a condotte inappropriate può configurare la loro qualità di persone offese. L'evoluzione giurisprudenziale testimonia un profondo mutamento culturale che ha investito la concezione dell'educazione e della correzione. Il superamento di modelli educativi autoritari e violenti rappresenta una conquista di civiltà che trova nella giurisprudenza di legittimità un presidio fondamentale per la tutela dei diritti dei minori. La parificazione tra maltrattamenti diretti e assistiti, tanto sul piano sanzionatorio quanto su quello risarcitorio, riflette una comprensione più matura del danno psicologico che l'esposizione alla violenza può determinare nei soggetti in età evolutiva. Ogni forma di aggressione fisica o psicologica è incompatibile con la funzione educativa e configura necessariamente condotte penalmente rilevanti, indipendentemente dalle motivazioni soggettive dell'agente e dalle sue origini culturali. La tutela del minore, sia come vittima diretta che come testimone di violenza, rappresenta oggi un valore irrinunciabile dell'ordinamento, che non ammette deroghe né eccezioni, costituendo il fondamento stesso di una società civile orientata al rispetto della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo.
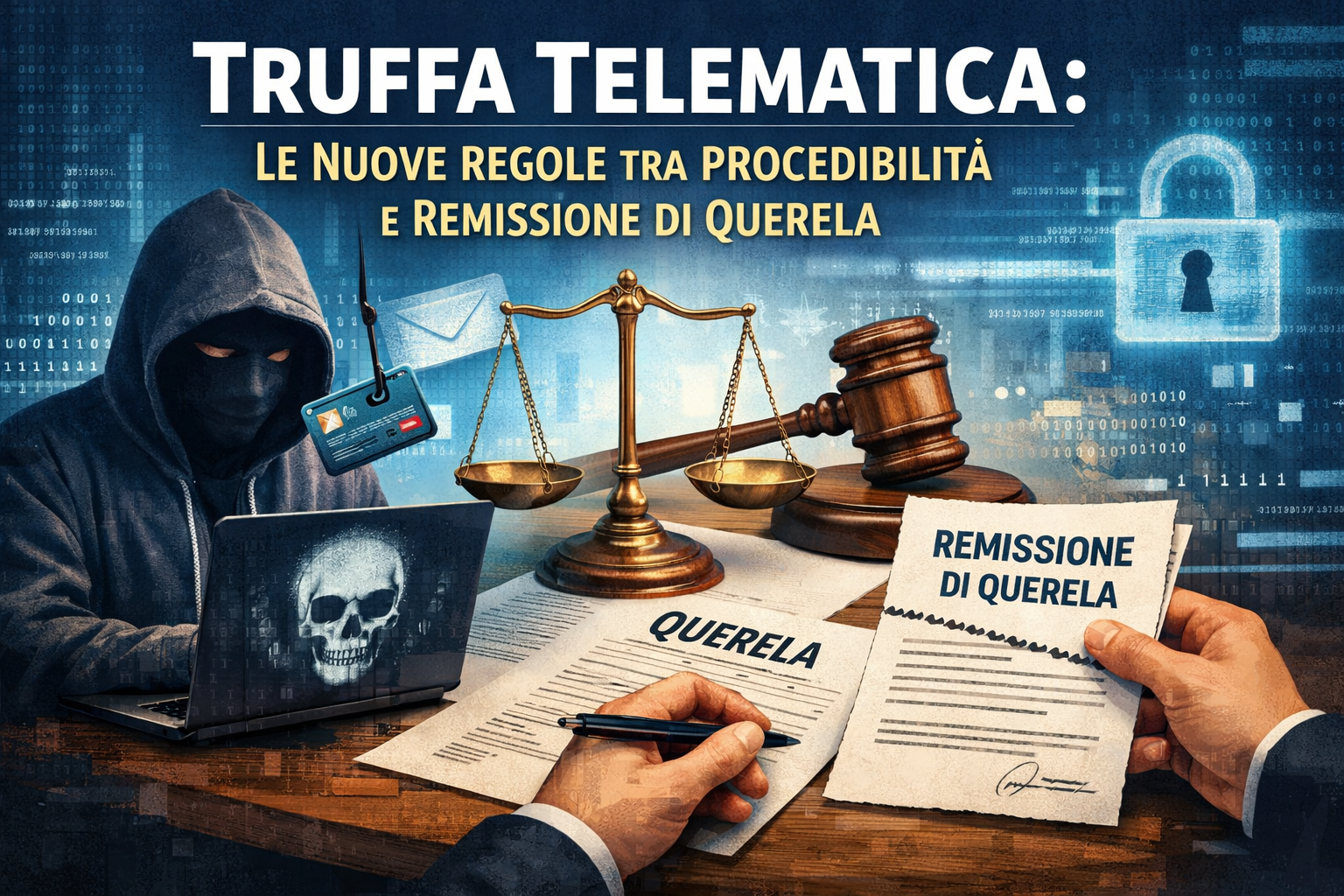
Autore: Angelo Cafà
•
27 gennaio 2026
Le recenti riforme legislative hanno ridisegnato il quadro normativo delle truffe commesse attraverso strumenti informatici, introducendo significative innovazioni che meritano un'attenta considerazione. Una recente pronuncia della Cassazione ha recentemente chiarito i principi applicabili, delineando i nuovi equilibri tra tutela delle vittime e garanzie processuali. La legge n. 90 del 2024 ha introdotto nell'articolo 640 del codice penale il comma 2-ter, configurando un'aggravante specifica per la truffa commessa "a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore". L'innovazione più rilevante risiede nel regime di procedibilità: mentre in precedenza le truffe online erano procedibili d'ufficio in quanto aggravate dalla minorata difesa, la nuova fattispecie è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa. Questo mutamento, in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, si estende anche ai fatti commessi anteriormente alla riforma, determinando un concreto beneficio per gli imputati attraverso la possibilità di estinzione del reato per remissione di querela. Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha parallelamente modificato l'articolo 152 del codice penale, introducendo una forma specifica di remissione tacita che opera quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che tale meccanismo non opera automaticamente. Il giudice deve accertare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti normativi, verificando che l'assenza sia effettivamente ingiustificata e riconducibile a una scelta libera e consapevole del querelante. La mera mancata comparizione all'udienza predibattimentale non integra di per sé un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Queste modifiche comportano rilevanti conseguenze pratiche. Le vittime di truffe telematiche devono ora necessariamente presentare querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto per attivare l'azione penale, ma conservano la facoltà di rimettere la querela determinando l'estinzione del reato. Particolare attenzione deve essere prestata alle conseguenze processuali della non comparizione quando si sia citati come testimoni. Il legislatore ha voluto evitare che l'inerzia processuale si traduca automaticamente in rinuncia all'azione penale, richiedendo una valutazione caso per caso delle circostanze concrete. L'evoluzione normativa testimonia l'impegno del legislatore nell'adeguare il sistema penale alle nuove forme di criminalità digitale, contemperando l'esigenza di tutela delle vittime con i principi di proporzionalità e favor rei. La giurisprudenza sta contribuendo a definire i contorni applicativi delle nuove disposizioni, garantendo un'interpretazione rispettosa delle garanzie costituzionali e processuali. Per i professionisti del diritto e per i cittadini risulta essenziale mantenersi aggiornati su questi sviluppi, che modificano sostanzialmente l'approccio a una delle fattispecie criminose più diffuse nell'era digitale, richiedendo nuove competenze e strategie difensive adeguate al mutato panorama normativo.

Autore: Angelo Cafà
•
14 gennaio 2026
La violenza sulle donne non è un’emergenza episodica, ma una questione strutturale che interroga il diritto, la cultura e la responsabilità collettiva. Con questo spirito si è svolto il 25 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Pinacoteca del Comune di Gela (Viale Mediterraneo, 47), il convegno promosso dall’Associazione “Diritto & Donna – Città di Gela” APS, presieduta dalla manager Rosa Iudici. In un contesto di confronto serio e partecipato, giuristi ed esperti hanno analizzato il fenomeno sotto il profilo legale, sociale e psicologico, soffermandosi sulle criticità del sistema di tutela e sulle soluzioni concrete da rafforzare: prevenzione, protezione delle vittime, efficacia delle misure cautelari, formazione degli operatori e coordinamento tra istituzioni. A moderare l’incontro la giornalista Desideria Sarcuno, che ha guidato il dibattito valorizzando la pluralità dei contributi: Rosa Iudici, Presidente “Diritto & Donna – Città di Gela” APS Salvatore Scuvera, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Valentina Lo Porto, Avvocato Angelo Cafà, Avvocato Claudia Scalia, Avvocato Il confronto ha ribadito un punto essenziale: la risposta alla violenza richiede competenza, continuità e responsabilità, non slogan. Il diritto può e deve essere strumento di protezione effettiva, ma solo se accompagnato da una rete solida, da prassi coerenti e da una cultura del rispetto che si costruisce ogni giorno. Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: ascoltare, intervenire, prevenire non è un’opzione, è un dovere.

Autore: Angelo Cafà
•
14 gennaio 2026
Gela – In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne , l’Istituto Morselli di Gela ha ospitato un incontro organizzato dalla Presidente della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Giusi Rinzivillo, in collaborazione con il Lions Club Gela ATC, presieduto da Giambattista Mauro. L’evento si è rivelato un’importante occasione di sensibilizzazione e formazione rivolto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di combattere la violenza di genere e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza. La giornata è stata caratterizzata da interventi di grande impatto, a partire dai monologhi degli studenti dell’istituto, coordinati dalle Prof.sse Giuliana Cottone e Concetta D’Aleo. Questi giovani talenti hanno dato voce a “anime spezzate”, rendendo palpabile il dramma delle vittime attraverso racconti che hanno toccato il cuore e la coscienza dei presenti. La loro performance è stata un autentico inno alla vita e alla dignità, dimostrando la capacità delle nuove generazioni di affrontare tematiche delicate con sensibilità e profondità. A seguire, sono intervenuti esperti del settore, tra cui l’Avvocata Carolina Macrì, appartenente alla FIDAPA e al Foro di Gela, e l ’avvocato penalista Angelo Cafà . Entrambi hanno affrontato la questione del femminicidio e della violenza di genere utilizzando un linguaggio diretto e comprensibile, illustrando le legislazioni più avanzate in materia. Gli interventi degli avvocati si sono distinti per la loro completezza ed efficacia, fornendo agli studenti chiavi di lettura importanti per comprendere non solo la normativa vigente, ma anche le implicazioni sociali e psicologiche delle violenze subite dalle donne. Paola Sbirziola, psicologa e psicoterapeuta, ha concluso l’incontro con una proiezione di slide altamente informative studiate per indurre gli studenti a riflessioni profonde. Le immagini e i dati presentati hanno stimolato profonde riflessioni, lasciando ai ragazzi strumenti critici per affrontare la problematica della violenza di genere nella loro quotidianità. Ad aprire l’evento è stato il Dirigente scolastico, Franco Ferrara il quale ha riservato un’accoglienza calorosa sia ai relatori che alla moderatrice Prof.ssa Rinzivillo. La sua introduzione ha posto l’accento sull’importanza di tali discussioni all’interno delle scuole, sottolineando il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione della violenza. Grande merito va anche agli studenti, il cui comportamento encomiabile ha dimostrato un forte senso di responsabilità e maturità. La loro partecipazione attiva e il loro interesse hanno reso l’incontro ancora più significativo, trasformando la giornata in un momento di crescita non solo per loro, ma per tutta la comunità. L’incontro all’Istituto Morselli rappresenta, dunque, un passo importante verso una maggiore consapevolezza e impegno nella lotta contro la violenza di genere. È fondamentale continuare su questa strada, affinché le nuove generazioni possano essere ambasciatori di cambiamento e promotori di una società più giusta e rispettosa. fonte: notiziefuoritotta.it

Autore: Angelo Cafà
•
14 gennaio 2026
Si è svolta nell’aula conferenze del Liceo scientifico e linguistico “Elio Vittorini” la presentazione del corso di autodifesa “Difenditi. Riconoscere, reagire, rinascere”, un progetto dedicato a tutte le ragazze delle classi quinte dell’istituto, circa 120 studentesse. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire alle giovani donne, prossime ad affrontare il passaggio alla vita universitaria o lavorativa, strumenti concreti per riconoscere situazioni di rischio, reagire in modo efficace e muoversi con maggiore consapevolezza in contesti nuovi. Il corso sarà guidato dall’istruttore Vincenzo Lombardo, affiancato da Melania Annaro tecnico della riabilitazione psichiatrica, che ne cureranno tanto gli aspetti tecnici quanto quelli psicologici e preventivi. Le sessioni pratiche si svolgeranno il 26 e 27 novembre presso la palestra del Liceo. A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica, Ina Ciotta, che ha accolto istituzioni, relatori e associazioni promotrici, ringraziando in particolare l’Associazione degli ex studenti del Liceo Vittorini e l’Associazione Orizzonte Europa per l’impegno nell’organizzazione. Sono intervenuti anche l’assessore ai Servizi Sociali Valeria Caci, l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina, la presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice, il delegato di Orizzonte Europa Gaetano Arizzi e il consulente per le Politiche Giovanili del Sindaco di Gela Giuseppe Gallo. È intervenuto anche il presidente dell’Associazione degli ex studenti Elias d’Aleo, moderatore dell’incontro, che ha sottolineato l’importanza di proporre percorsi formativi rivolti alla sicurezza e all’autonomia personale delle studentesse. La conferenza ha visto poi gli interventi dell’ispettore capo della Polizia di Stato Alberto Oliveri, di Selenia Campanaro, psicologa e responsabile dello sportello antiviolenza “Diana” – CoTuLeVi e dell’ avvocato penalista Angelo Cafà : Melania Annaro e Vincenzo Lombardo hanno infine presentato nel dettaglio gli obiettivi e la struttura del corso che sta per partire. L’evento si è concluso con l’invito rivolto alle studentesse a vivere l’esperienza non come un semplice laboratorio fisico, ma come un percorso di crescita, consapevolezza e autodeterminazione. fonte: ilgazzettinodigela.it
DIFESA NEL PROCESSO PENALE
Lo Studio, specializzato in diritto penale, si occupa della difesa dell' indagato, imputato o persona offesa, in ogni sua fase processuale, compresa quella dell’esecuzione della pena.
Scopri di più
RESPONSABILITA' MEDICA
Consulenza legale altamente qualificata e mirata alla tutela dei diritti dei pazienti e dei professionisti sanitari.
VIOLENZA DI GENERE
Difesa dinanzi l'Autorità Giudiziaria, in tutte le fasi del processo penale
e civile.
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Consulenza e assistenza legale qualificata in materia di bullismo e cyberbullismo, garantendo tutela effettiva alle vittime di comportamenti persecutori, molestie, diffamazione online, minacce e violazioni della privacy.







